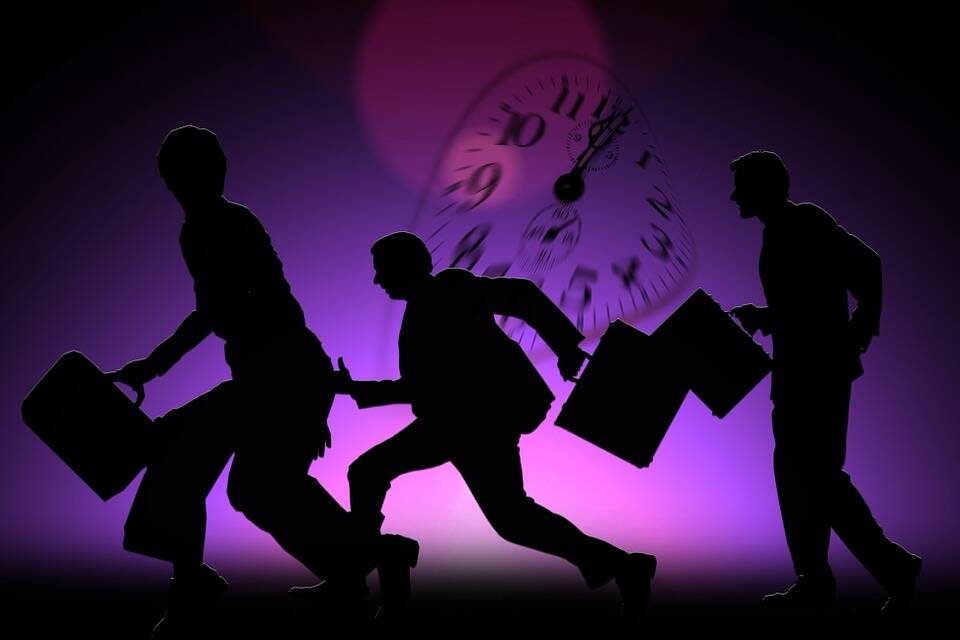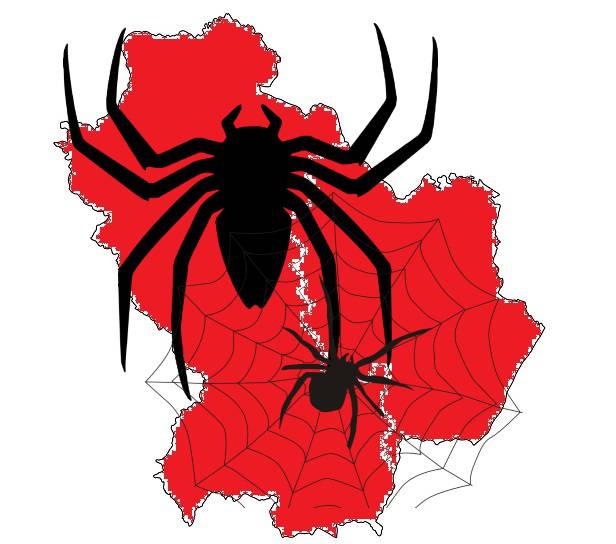La Basilicata e il rischio di una nuova “mafia”

I nuovi professionisti della politica, i colletti grigi e i circuiti di scambio a livello locale
Ormai in Basilicata i tempi sono maturi per almeno due domande su cui riflettere e provare a dare delle tracce riguardo ad altrettanti fenomeni: l’affermarsi di una nuova classe di professionisti della politica specializzati nell’organizzazione del consenso e nella mediazione tra cittadini-elettori, imprese, partiti e centri di spesa pubblica; e il consolidarsi di quella che abbiamo chiamato “non mafia” ma che in sostanza potrebbe evolversi in un altro tipo di “mafia” che si sviluppa attraverso sistemi locali economici, politici e di affari. Questa tipologia di “nuova mafia”, si starebbe insediando in territori, tra cui la Basilicata, che nulla hanno a che fare con quelli caratterizzati tradizionalmente dalle mafie conosciute. Perciò, come abbiamo già scritto altrove, difficile da riconoscere e individuare ricorrendo alle categorie e alla giurisprudenza di cui dispongono oggi gli inquirenti. I due fenomeni potrebbero, in una logica interpretativa, legarsi con la crisi della rappresentanza dei partiti e con l’espandersi del civismo localistico che in qualche modo ha rafforzato la propria influenza sulle formazioni politiche nazionali.
Dunque riconoscere la “non mafia”, come condizione determinata da una cultura della mafiosità, che rischia di trasformarsi nel tempo in una nuova “mafia” inedita e completamente sganciata dalle vecchie categorie, non è operazione semplice. Tuttavia, abbiamo il dovere di mantenere viva la questione nel tentativo di scongiurare l’affermarsi in Basilicata di un sistema, sostanzialmente criminale, ma dal profilo formalmente legale: una sorta di imprenditoria politica legata a quella economica e affaristica, in qualche modo infiltrata nelle istituzioni, fondata essenzialmente sullo scambio corruttivo.
E’ sufficiente notare come da almeno 20 anni si siano affermati nell’ambito amministrativo locale reticoli e gruppi di interesse, che si affacciano all’esterno dei perimetri istituzionali, legati a un ceto politico di medio e basso livello specializzato nella costruzione e gestione di circuiti di scambio non sempre corruttivi in senso stretto, ma spesso illegittimi (clientele, favoritismi, scambi di convenienze). Siamo in presenza di politici-mediatori e faccendieri con una forte capacità persuasiva e con significativi contatti con i livelli istituzionali più alti.
“Il reticolo si presenta essenzialmente nella sua dimensione politica a cui si aggiungono tratti di mafiosità: tramite le leve del potere ottiene vantaggi e prebende per la parte imprenditoriale. Ma per mantenere tali posizioni e connessioni deve operare anche sul piano dei rapporti politici e del consenso elettorale, come fosse un partito o una sua corrente, gestendo il proselitismo per i propri membri e per gli alleati. Si configura la natura politica di gruppo orientato all’accumulazione di potere con lo scopo di ottenere risorse pubbliche.” (Luciano Brancaccio, 2016). “Il gruppo, inoltre, agisce in modo da garantirsi l’elezione di personale politico di propria fiducia.”
E’ evidente in Basilicata che questi reticoli si configurano come “un’associazione politica a tutti gli effetti che si coordina nel nome di comuni interessi di carattere materiale, prescindendo dalla tradizionale collocazione dei componenti nello scenario ideologico e politico.” Il partito eventuale di appartenenza nulla c’entra con gli scopi e con le decisioni assunte dalla cerchia d’affari. Tra l’altro, è noto il fenomeno della nascita di liste e simboli nuovi ad ogni competizione elettorale amministrativa e il passaggio repentino da una fazione all’altra di alcuni candidati o promotori di candidati. Le liste civiche, fatte le dovute eccezioni, spesso si configurano come un insieme di persone reclutate a fini strumentali, anche a loro insaputa, da professionisti del consenso e della mediazione. Spesso si tratta di aggregazioni estemporanee che si sciolgono o si trasformano subito dopo le elezioni.
Una parte importante in queste dinamiche è giocata sulla crisi dei partiti. Crisi che ha innescato l’uso di nuovi strumenti di raccolta del consenso nei circuiti di scambio politico-clientelare concentrati nella dimensione locale. Scrive Brancaccio: L’analisi delle organizzazioni di partito ha negli ultimi decenni messo in evidenza un processo di mutamento verso una progressiva individualizzazione nel rapporto tra elettori e rappresentanti politici, e tra rappresentanti politici e formazioni di partito. Il panorama attuale è molto diverso da quello che, tra gli anni cinquanta e ottanta del secolo scorso, vedeva in primo piano partiti organizzati, con ampie strutture burocratiche, sia nella forma del partito di massa, sia nel la forma del partito clientelare di massa. (…) I processi di cambiamento realizzatesi negli ultimi venti anni vanno dunque nella direzione di una ridefinizione delle aggregazioni politiche a livello locale. Un personale politico locale relativamente autonomo dai partiti, capace di organizzare il consenso elettorale secondo un modello di micronotabilato, aggregazioni politiche poco istituzionalizzate, un nuovo professionismo nei ranghi medio-bassi con competenze specializzate di intermediazione costituiscono gli elementi base che favoriscono una particolare configurazione dei circuiti politico-affaristici, più frammentati ma anche dotati di elementi di tenuta interna, forme associative che possiamo ricondurre alla fattispecie sociologica dei quasi-gruppi e in particolare delle cricche e delle fazioni politiche.
Dunque, senza fare di tutta l’erba un fascio, dal nostro osservatorio avvertiamo l’esistenza in alcuni Comuni lucani e in altre istituzioni di livello superiore, in diversa misura, delle dinamiche appena descritte. Il micro-notabilato è in pieno funzionamento. Lo ricaviamo dai molti articoli apparsi su questa testata che ha lanciato l’allarme su episodi di scambio politico-affaristico non sempre attenzionati dalla magistratura e dalle altre autorità. D’altronde, basta ricordare la cronaca giudiziaria degli ultimi 20-30 anni per avere un quadro più chiaro delle questioni trattate in questo articolo. Da quella cronaca, però, non emerge il rischio che si possa affermare una nuova “mafia” inedita. I fatti appaiono isolati e distaccati. Tuttavia, uno sguardo più ampio e approfondito ci porta a considerare quel rischio. Il fenomeno corruttivo è in forte espansione. Allo stesso modo le probabilità di utilizzo privato delle risorse pubbliche crescono notevolmente. La scarsa attenzione a questi fenomeni alimenta l’attività dei colletti grigi e delle cricche capaci di aggregare le domande particolaristiche a livello locale nel quadro di alleanze tra pubblici funzionari, imprenditori, esponenti politici e delle istituzioni. A volte queste cricche sono aperte a personaggi legati alla criminalità organizzata e non organizzata.
©Riproduzione riservata
 0
0