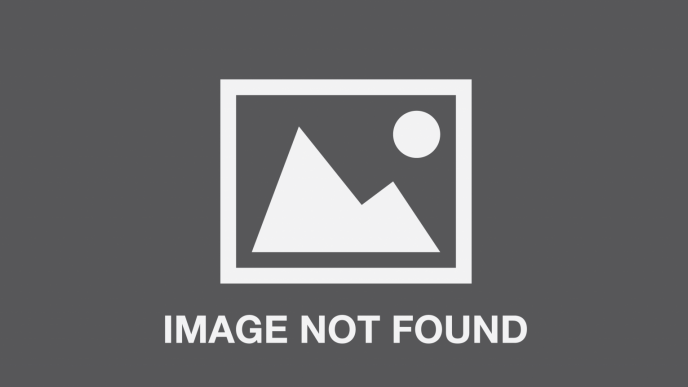
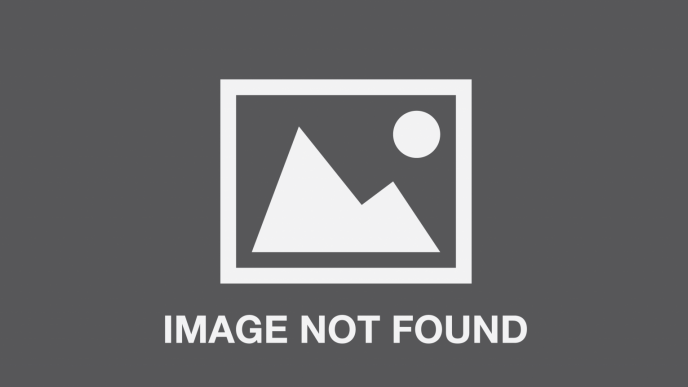
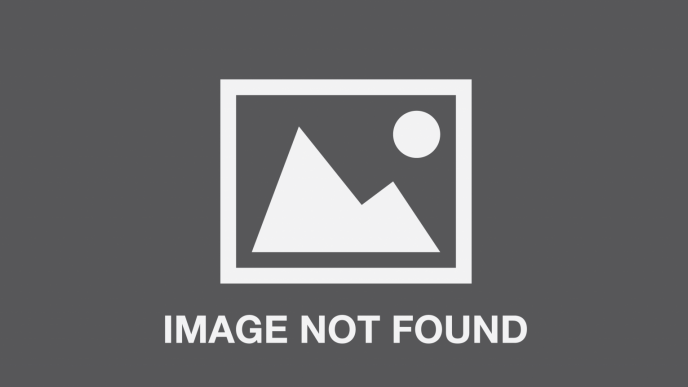
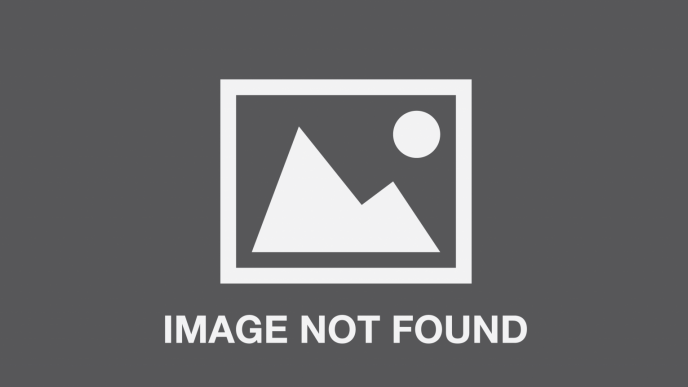
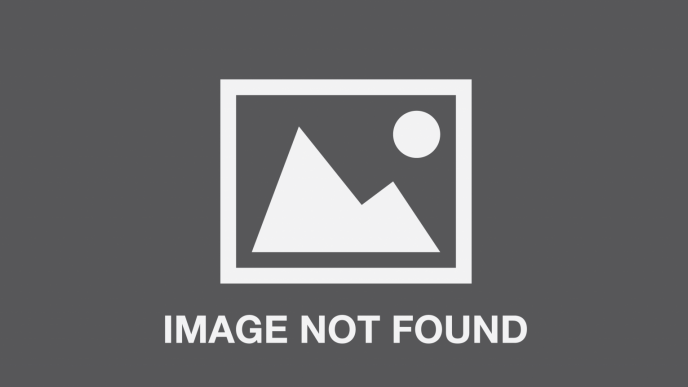
Remo, Antonio, Emilia. Nomi come tanti. Ma c’è un particolare. Appartengono alla lunga lista di operai deceduti perché lavoravano l’amianto nello stabilimento Eternit-Saca Cemento Amianto Spa di Cavagnolo
Sono 97 in totale. A cui vanno aggiunte 46 persone che oggi si vivono una patologia asbesto-correlata. E Cavagnolo non è un caso isolato. Ci sta Casale Monferrato. L’elenco dei morti in questo caso occupa oltre 30 pagine. Sono più di 1000, mentre 416 si vivono tutt’ora un inferno chiamato mesotelioma, tumore polmonare, asbestosi.
AMIANTO PUBBLICO – Anche la Basilicata ha una storia d’amianto. Una lunga storia che arriva fino a oggi ma inizia in Val Basento nei primi anni ’70. In un paese, l’Italia, che vedeva l’intero comparto industriale in crisi ed Eternit Italia, per un’erosione del capitale sociale, in una situazione pre fallimentare. Sull’orlo del fallimento e consapevole dei danni provocati dall’amianto, come riporta una lettera del ’72 tra due dirigenti di Casale Monferrato, la multinazionale investe negli stabilimenti italiani. In questo contesto economico s’insediava, in Val Basento, l’azienda pubblica Cemento Amianto Matera Spa (Cemater, ndr), nata nel Novarese col nome di Nordamianto Spa che nel ’71, dopo l’ingresso nel capitale sociale della Icar, della Spi del gruppo Iri (ex Istituto per la ricostruzione industriale dello Stato, ndr), e della Cementir del gruppo Iri-Finsider, diventa Cemater e sposta la sua sede dal nord al povero sud bisognoso di clonare, come per la chimica, produzioni già in crisi nel resto d’Italia. Sino al ’78 comunque, precisamente durante l’anno dello shock petrolifero, la Cemater se ne sta buona. Non produce granché e fa per lo più prove. Testa prodotti – ricordano i lavoratori – da immettere sul mercato. E testa pure gestioni. Ci girano intorno società come la Icar di Rubiera finita nel processo di Torino. Oggi gli stessi ex operai ricordano quei loro compagni che proprio dall’Icar furono assunti. Poi venne la Posital. E ancora: Vic. Infine, negli anni ’80, arrivò il terremoto che colpì la Campania e la Basilicata. E arrivò, per volere del Gruppo Iri già operativo con Eni nella chimica in Valbasento, il Gruppo Fibronit e la produzione per l’edilizia. Dieci anni dopo nasceva la Materit spa.
LA SINDROME DA ULTIMA POSSIBILITA’– Morti a parte, col sisma che interessò il 45% del territorio e oltre metà della popolazione, la regione fu irrorata di danaro, e per l’occasione iniziò ad andare di moda tra politici e industriali l’inglesismo “last opportunity syndrome”. Era l’ultima occasione per uscire dal sottosviluppo in cui si viveva al sud. In una ricerca dell ’87 dal titolo “Il caso Basilicata” gli autori scrivono che il terremoto è stato per la regione “un evento che ha contribuito sotto due aspetti alla maturazione dell’identità regionale: da un lato, proiettando l’immagine istituzionale e il peso politico della Basilicata all’esterno, in uno scontro con lo Stato per limitare il controllo centralistico del processo di ricostruzione, dall’altro mettendo la Basilicata di fronte alla necessità di rafforzare, al suo interno, i rapporti con enti e imprenditori locali per attivare le prospettive di sviluppo legate agli investimenti per la ricostruzione”. Quello della ricostruzione, ricorda la ricerca, fu anche il periodo in cui venne imposta una nuova politica industriale. Ma chi ha guadagnato dagli oltre 50mila miliardi di vecchie lire stanziati? Grazie al regime della deroga quella montagna di soldi ingenerò un sistema fortissimo di collusione tra imprese, politici, mafiosi, come ribadito dalla Commissione sulla Camorra del ’93. E banche. La stessa Banca d’Italia confermò che nelle casse degli istituti bancari erano affluiti miliardi e miliardi di lire, e la Commissione d’inchiesta sul terremoto condannò apertamente come sulla sciagura s’erano costruite le fortune degli istituti bancari interessati (per lo più banche e casse di risparmio, ndr). Precisamente 61 in Campania con una popolazione di 5,5milioni di abitanti, e ben 23 in Basilicata con i suoi scarsi 600mila.
IL BOOM BANCARIO IN BASILICATA-Tutto ciò avveniva in un contesto che Carlo Sorrentino, nel suo “Modernizzazione e sistema politico in Basilicata”, ricorda come di squilibrio tra la nascente struttura economica e il permanere d’una struttura culturale tradizionale, squilibrio che qualora non avesse trovato adeguate fonti di bilanciamento, poteva “essere la causa di un fenomeno mafioso”, e di pratiche che definiva proprie dell’imprenditorialità mafiosa. In questo contesto entrava a pieno regime la Materit, producendo anche onduline pubblicizzate dopo il terremoto come tetti indistruttibili. La manna santa dell’edilizia popolare, per costi contenuti e resa nel tempo, cominciava a invadere il mercato locale delle costruzioni in un momento in cui arrivava una pioggia di finanziamenti pubblici.
RIFIUTI INDUSTRIALI DA SMALTIRE- Che la Materit fosse a pieno regime lo conferma il fatto che vi era una produzione di rifiuti industriali così elevata da diventare un serio problema per lo stabilimento, tanto da farne temere la chiusura. In una corrispondenza del ’88 l’ingegner Mò, ex Dirigente dello stabilimento in Valbasento, poco dopo aver avuto contatti con il Direttore generale Matteo e il direttore tecnico Vizziello del Consorzio industriale di Matera (Asi, ndr) ai quali aveva chiesto d’interessarsi al problema dello smaltimento dei rifiuti industriali, fa un appello urgente al presidente dell’Asi ricordandogli che la Materit produceva dal ’84 manufatti in amianto-cemento. Quante tonnellate di questi manufatti siano state concretamente disseminate sul territorio lucano da quella data non lo si può sapere. Di certo 28anni dopo resta eternit in enormi opifici abbandonati, aziende agricole e zootecniche, paesi e città come Potenza e Matera. In luoghi turistici come Monticchio. E sparpagliato tra campagne, boschi, fiumi. Smaltito senza criterio. Manufatti e resti spesso degradati che interagiscono con animali, campi coltivati, esseri umani. O da cui si fanno, quasi per beffa, case in cui mettere gli stessi terremotati.
– Noi sapiamo che il picco di patologie asbesto-correlate arriverà nel 2020. Nel frattempo si attende, e ci possiamo fare solo una vaga idea della quantità dei prodotti smerciati attraverso le parole del dirigente Materit quando ricorda al presidente Asi le quantità di rifiuti di fabbrica “inevitabilmente” generate per produrre quei manufatti. Ogni anno 500mila chili di fanghi di processo e 1milione tra rottami e sfridi di prodotti di scarto. Negli anni in cui la fabbrica è stata operativa sul mercato per conto di Fibronit, gli anni d’oro post-sisma, andiamo a oltre 2milioni e mezzo di chili di fanghi e 5milioni in rottami e sfridi. Una montagna di rifiuti e di prodotti.
A CASALE SI VIETAVA LA LAVORAZIONE DELL’AMIANTO A FERRANDINA NO- A dicembre del ’87, in seguito a un’ordinanza del sindaco a Casale Monferrato fu vietata la lavorazione dell’amianto. Così la produzione, ricorda la sentenza di Torino, aumentò nella Fibronit di Broni, e si ipotizza sia avvenuto lo stesso alla Fibronit di Bari. Ciò avrebbe comportato l’aumento della quantità di polveri e fibre d’amianto disperse in aria. Nel quartiere Japigia a Bari, dove operava lo stabilimento pugliese, sono documentati casi di cancro da patologie asbesto-correlate per “esposizione ambientale” su una signora di 65 anni e una ragazza di 35. Età molto diverse, e persone che non hanno mai lavorato l’amianto. Unica pecca: abitare vicino la fabbrica. E la Fibronit in Val Basento? Opera in un periodo, come abbiamo detto, in cui miliardi e miliardi di vecchie lire circolavano in regione grazie al terremoto e agli appalti per la ricostruzione. Uno stabilimento, quello Materit, in cui hanno lavorato 86 unità, tutti esposti direttamente per le assurde condizioni di lavoro e veicolo d’esposizione per mogli e figli, alla media, afferma la medicina del lavoro di Matera, di 2,3 soggetti per operaio. In quel 1987 dunque, mentre a Casale si fermava la produzione con amianto, la Materit andava a vele spiegate. In effetti sette mesi prima dell’ordinanza di Casale che ne vietava la lavorazione, si legge in un documento interno che Giuseppe Padula, capo sezione igiene e sanità del Comune di Matera firmò un’autorizzazione d’un anno alla Dima srl per lo smaltimento in discarica di 100 metri cubi di rifiuti speciali “assimilabili all’urbano”. Un’operazione non casuale dal momento in cui appena due mesi prima il Direttore di fabbrica Mò scriveva all’Asi di Matera d’interessarsi “urgentemente” al problema dei rifiuti prodotti e ormai fuori controllo, specificando che era noto che non ci fossero discariche pubbliche in esercizio in regione e che lo stoccaggio temporaneo aveva “raggiunto dimensioni tali da rendere problematico l’ulteriore accumulo”. Così il Comune di Matera autorizzava per un anno un’impresa locale a smaltire i rifiuti Materit “assimilati agli urbani” in una non specificata discarica, e l’ingegner Mò ribadiva al presidente Asi, dopo aver avuto notizia che il Consorzio già disponeva d’una “autorizzazione regionale” per una discarica in territorio di Pisticci che stava allestendo, d’interessarsi affinché anche i loro rifiuti finissero lì nei tempi più brevi possibili. Così mentre a Casale si bloccava la produzione, la Materit di Ferrandina, come accaduto per Broni e Bari, era tanto produttiva da presentare una situazione definita drammatica per lo smaltimento dei suoi rifiuti. E anche in quest’area del materano, ovviamente, sarà aumentata la dispersione delle polveri e i relativi effetti collaterali.
RIFIUTI CHE VANNO, CENERI CHE VENGONO- Di certo sappiamo, grazie a documenti interni che abbiamo trovato nello stabilimento, che pochi mesi prima del sequestro della fabbrica viene firmato un contratto di smaltimento rifiuti industriali. Non si tratta di forniture, ma è un documento importante. Attesta la relazione tra la Materit del Gruppo Fibronit di Ferrandina, nel materano, e lo stabilimento di Casale Monferrato. A siglarlo è la Materit con sede legale – si legge – a Borgo Macchia di Ferrandina, ma con Direzione generale e amministrazione a Casale Monferrato. La società di Napoli che gestirà quei rifiuti il contratto lo intesta invece alla Materit spa di Via Mameli 4 a Casale Monferrato. E nella scheda descrittiva dei rifiuti colpisce un particolare. Viene riportato che Ferrandina è l’insediamento produttivo da cui prendere i rifiuti industriali, ma che la sede legale è proprio Via Mameli 4 a Casale. In quei fanghi di decantazione, tossici se ingeriti, la cui discarica di destinazione appartiene alla Di.Fra.Bi di Napoli, stando alle sostanze riportate nel contratto ci stanno metalli pesanti come composti di rame solubili, cadmio e piombo (e relativi composti), e ovviamente amianto, in polveri e anche in pericolosissime fibre. Materiale che era tenuto come mucchio sul terreno. Ma perché compaiono metalli pesanti? Forse per spiegarlo è utile una bolla di accompagnamento di materiale arrivato risalente al gennaio ’83, che abbiamo ritrovato negli uffici della fabbrica, abbandonata come tanti altri documenti tipo report sulla pericolosità dell’amianto e nonostante il sequestro giudiziario dello stabilimento.
IL BUSINESS DELLE BONIFICHE- Ma l’amianto è un problema serio. E un affare. Pare che in Basilicata se ne sia accorto persino un boss della ‘ndrangheta. Uno che si prendeva cura di appalti pubblici e che intercettato ha messo in evidenza una fitta rete di relazioni con politici, imprenditori, avvocati, funzionari pubblici. Nell’inchiesta Iena2 il gip riporta quanto avvenuto per la “bonifica amianto” delle coperture dell’Azienda Agricola Sperimentale Dimostrativa a Pantano di Pignola, che fa parte di quelle A.a.s.d sparse per la Basilicata che appartengono all’Agenzia lucana per l’innovazione e lo sviluppo in agricoltura (Alsia, ndr), “strumento operativo della regione Basilicata nel sistema agroalimentare”, con delega all’esaurimento della Riforma Fondiaria. Nel caso specifico, a luglio del 2001 interloquendo al cellulare con un imprenditore finito di recente in terra di Puglia in un’operazione per traffico transnazionale di rifiuti tossici, il boss affermava che nonostante i suoi molteplici impegni di “giustizia”, per l’appalto sulla bonifica amianto a Pignola “era tutto a posto”. Un mese prima che la gara venisse resa pubblica il boss già sapeva che quell’impresa avrebbe vinto l’appalto. Come effettivamente accaduto. Ma Alsia di tutto questo non sapeva nulla, e non sapeva nemmeno nulla di quanto avveniva in altri luoghi dove pure aveva effettuato interventi di messa in sicurezza amianto. Capitava nel Materano. Nel 2008. Mentre ignare mucche sgranocchiavano sfridi e pezzetti d’eternit in una discarica illecita, il referente dell’Alsia, intervistato in proposito, mi rispondeva che lì per 30mila euro circa era già stato raccolto tutto il materiale, insaccato, e la zona era stata isolata affinché nessuno potesse entrarvi e nulla potesse uscirvi. Da allora, sono passati altri due anni in cui mucche e pecore ci hanno mangiato dentro prima che l’area venisse effettivamente isolata. Non bonificata però, come tantissime altre situazioni presenti in terra lucana ove l’amianto resta al suo posto, non più indistruttibile.
E LA PROCURA?- La Materit resta una specie di zona franca dei rifiuti, un simbolo di illegalità in danno al territorio e alle comunità dove ogni tanto, i pozzetti di raccolta acque di pioggia dietro lo stabilimento, con vicino piezometri divelti che dovrebbero servire per capire lo stato di salute della falda acquifera, si trovano farciti d’un liquido nero e maleodorante. Nel 2005 comunque, da Casale Monferrato, l’avvocato Carlo Capra (curatore fallimentare della Materit srl, ndr) risponde al Comune di Ferrandina che la Materit ormai, era defunta. Come società fallita – specificava – non aveva più nessuna possibilità di bonificare il sito inquinato. Storia morta? Nedo Biancani, ex consulente per la Provincia di Matera, mi spiegava in un’intervista che la Materit è semplicemente un’altra di quelle situazioni della Val Basento su cui la Procura dovrebbe “mettere le mani”. L’amianto purtroppo, non è solo Casale.
 0
0
